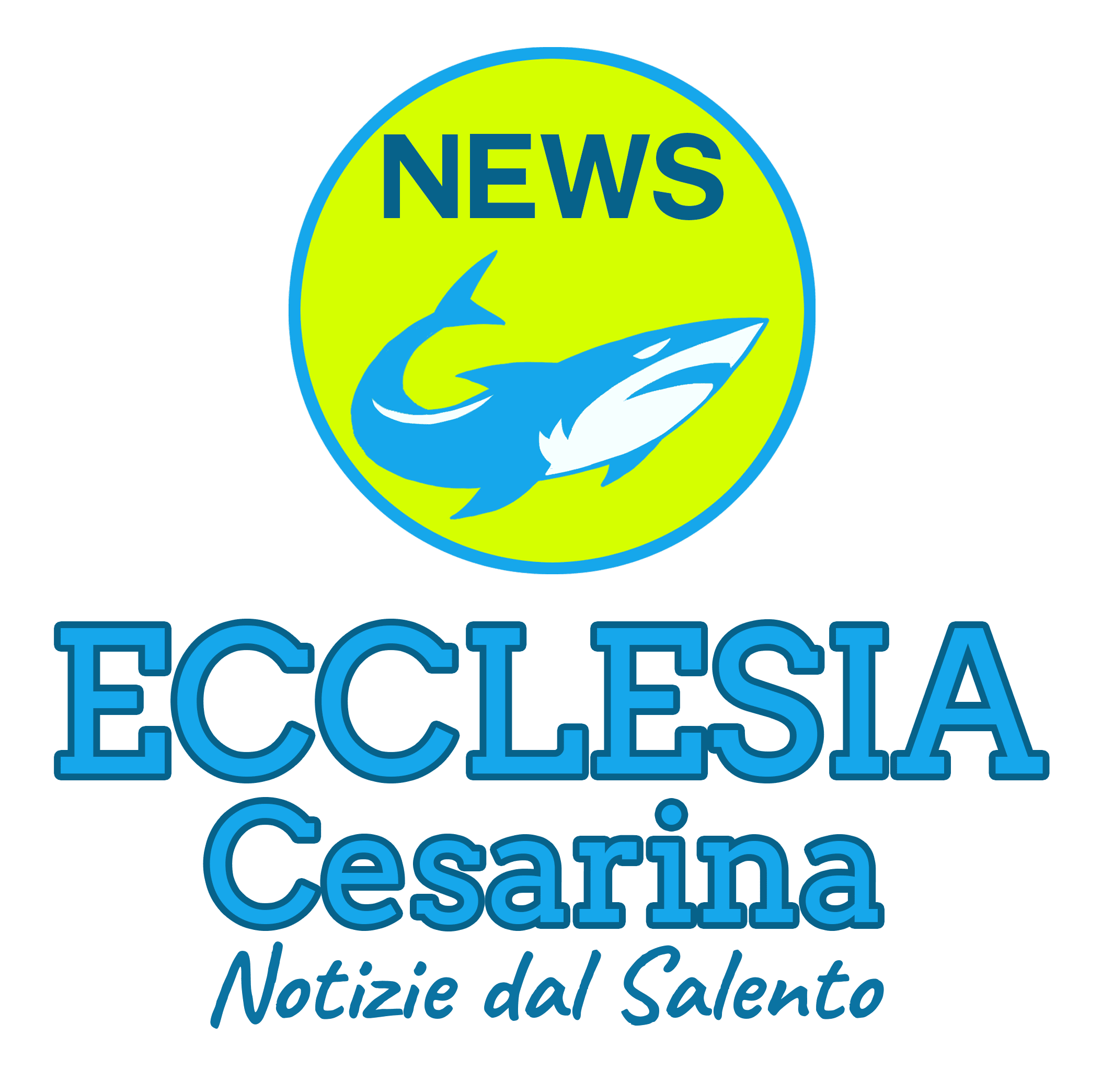Maria d’Enghien l’ascesa al potere di una donna forte e risoluta
a cura di Vittorio Zacchino
La storia di questa donna eccezionale prende le mosse nell’aprile 1347 quando, morendo in battaglia a Poitiers Gualtieri VI, viene ad interrompersi la signoria del Brienne sulla Contea di Lecce che durava dagli inizi del 1200. Siccome Gualtieri non ha eredi diretti, per garantire alla contea una continuità politica di segno angioino, gli viene fatto succedere il nipote ex sorore Giovanni d’Enghien, figlio di Gualtieri III e di Isabella Brienne. Questi è il padre della nostra Maria, avuta dalla moglie Sancia Del Balzo, unitamente a Pietro e a una terza figlia, presunta badessa benedettina a Conversano.
Nel 1376 Pietro d’Enghien, morto il padre, diventa Conte di Lecce. Ma dopo appena 7 anni di intense e logoranti campagne militari, muore a sua volta. Sicché nel 1384 è il turno di Maria, nata verso il 1367. A soli 17 anni viene chiamata alla responsabilità comitale in un momento delicato e di incertezze politiche. Maria prende in mano il governo della contea che ha un territorio assai vasto, con Lecce capoluogo di ben 24 casali. Con l’aiuto di due nobili e accorti tutori, Giovanni dell’Acaya e Pasquale Guarino, ne regge il peso non lieve. Fronteggia pericolose scorrerie di mercenari e turbolenze di feudatari.
La scelta strategica del matrimonio con Raimondello Orsini Del Balzo.
Adolescente ed inesperta, la giovane contessina leccese era cresciuta in una corte (il Palazzo dei Conti). Era un mondo di tradizioni medioevali che si avviavano al tramonto, sicuramente scarso di consuetudini cortesi e cavalleresche. Non aveva alcuna cognizione del difficile mestiere del comando. Inoltre ereditava l’obbligo antico della osservanza angioina, per effetto della quale diventava, ipso facto, avversaria del sovrano in carica Carlo III di Durazzo.
Maria però, ha il senso delle radici e il sangue di due antichissime stirpi come i Brienne e i d’Enghien. In breve prende coscienza della nodalità strategica della sua persona e della contea negli equilibri territoriali di Terra d’Otranto, e nel conflitto angioino – durazzesco per il trono di Napoli. L’anno dopo infatti, ella aderisce al matrimonio col famoso capitano Raimondello Del Balzo Orsini, conte di Soleto. Le sue gesta in terra santa risuonavano tutta l’Europa, ed entra stabilmente nell’orbita politica dell’accorto Luigi d’Angiò.
La coppia si destreggia con disinvoltura mercenaria e spregiudicatezza, tra papi e regnanti, riuscendo Raimondello a ottenere, in poco più di un decennio, l’investitura del principato di Taranto. Diventa il più potente barone del Mezzogiorno. Al fianco dello sposo Maria affina personalità, temperamento, abilità cavalleresca, ed acume politico. Insieme, in perfetta sintonia tra di loro, danno un forte impulso al loro stato che beneficia del loro mecenatismo illuminato. Fondano col favore papale l’ospedale di Galatina (1384) e fanno costruire altri monumenti prestigiosi come la Basilica di Santa Caterina d’Alessandria anche a Galatina (1391) e la trinata svettante guglia di Soleto (1397).
L’improvvisa morte del marito spinge Maria D’Enghien a muoversi in prima persona.
A Lecce, capoluogo della contea, l’affiatata coppia principesca attiva una corte signorile preferendo all’antico Palazzo Comitale il castello e l’amena torre di Belloluogo circondata di deliziosi giardini. Da allora le cure dello stato si alternano alle feste e alle giostre, e il Salento comincia a darsi un’identità culturale ed artistica. Contribuisce all’affermarsi dell’Umanesimo e del Rinascimento. La centralità della potente coppia negli scenari politici del tempo non ne insidia la compattezza e l’armonia del ménage coniugale.
La famiglia si accresce in breve di quattro figlioli: Caterina, Maria, Giovannantonio e Gabriele. Raimondello frattanto continuava a giocare le proprie carte con oscillante opportunismo e mero calcolo politico. Alla fine del 1405 si allontanava dalla fedeltà alla dinastia durazzesca di Re Ladislao, per riallearsi ancora con gli angioini di Luigi II. Ovviamente in cambio di concessioni adeguate. Ma il 17 gennaio 1406 egli usciva da questo mondo. Lascia alla moglie il peso del governo e quello dell’educazione e della collocazione strategica dei quattro orfani.
È venuto il momento per Maria d’Enghien di brillare di luce propria. Vissuta fino ad allora all’ombra del famoso condottiero, temuto e rispettato, Maria deve dimostrare finalmente, la sua avvedutezza politica e la sua personalità fuori dal comune. A cominciare da quello stesso 1406. Infatti, appena ebbe provveduto alle esequie del marito, ella si trasferì prontamente a Taranto, centro del principato. In direzione vi marciava Re Ladislao che non faceva mistero della sua volontà di spogliare del feudo i traditori Orsini – Enghien, per punirli del loro ritorno nelle file del rivale angioino.
Strenua resistenza agli assalti di Re Ladislao.
Il sovrano era convinto di sbrigare la pratica in brevissimo tempo. Non immaginava che la principessa gli si sarebbe opposta leoninamente. Del resto Maria era molto amata dai suoi vassalli ed affiancata da consiglieri fedelissimi. Di lei un biografo anonimo aveva scritto: “Maria d’Engenio, principessa di Taranto, oltre la bellezza del corpo, fu dotata di meravigliose doti d’animo, ed aveva in vita e dopo la morte del marito, con tanta prudenza e moderazione governato quei popoli, ch’erano prima per lasciarsi tagliare a pezzi e vedersi sbranare i figliuoli davanti agli occhi, che mancargli di fede”.
La virile principessa, armata di una panciera d’argento tutta ornata di gioie e con un elmo del medesimo metallo, sopra un corsiero bardato, tenne in scacco per oltre un anno, alla testa dei suoi soldati, l’agguerrito esercito di Ladislao. Rintuzzandone gli assalti, con spericolate sortite, fino a costringere il nemico a togliere il campo. La fama dell’amazzone leggendaria si diffuse in un baleno tra i popoli e i potenti, procurando unanimi simpatie alla bella virago leccese che si era opposta vittoriosamente ad uno dei più forti guerrieri dell’epoca. Maria comunque, che ha sagacia e intuito politico, non si fa troppe illusioni. Benché non tralasci l’attività diplomatica, si prepara con maggiore ardore alla resistenza armata.
Nel marzo 1407 il Re tornava a Taranto con un esercito più forte ed una flotta più potente, deciso a chiudere la partita. La resistenza è ancora più accanita dell’anno prima. La situazione si fa insostenibile e rischia il ridicolo, tanto che diversi baroni provano a persuadere il re nel rinunciare all’impresa. Ma a quel punto lo scaltro Gentile da Monterano, profondo conoscitore dell’animo femminile e sicuro della sete di ambizioni e di gloria della principessa, insinuò a Ladislao di chiederla in sposa.
Matrimonio di reciproca convenienza tra Maria d’Enghien e Re Ladislao
Gabriele Capitignano, emissario della principessa, le portò l’inusitata ambasciata. Quale donna avrebbe mai rifiutato di cingere una corona di regina? Scrive Alessandro Cutolo, il più importante dei suoi biografi: “Divenire regina! Allo sconfinato suo orgoglio mai tale speranza era apparsa. Per la prodigiosa luce che balenava a lei sullo sfiorire della sua giovinezza Maria (oramai vicina ai 40 anni) dimenticò tutto: il marito amato e da sì poco tempo perduto, l’odio che doveva albergarle nell’animo contro l’implacabile suo nemico, il pensiero dell’avvenire dei figli”.
Il miraggio di sedere sul trono di Napoli, al fianco di un sovrano che aveva sedici anni meno di lei, travolse la matura e bella Maria. Ma forse nella sua decisione non mancava una lucida speranza: di poter conservare il possesso degli aviti domini e di salvare la splendida tradizione della sua stirpe.
Invano i suoi baroni tentarono di dissuaderla dal grave passo, prospettandole l’eventualità di essere uccisa. “Nun me nde curo – pare abbia risposto – che se moro, moro regina”. In realtà il vantaggio maggiore lo otteneva Ladislao il quale, con l’insolita e bizzarra proposta di nozze, aveva l’opportunità di chiudere una guerra dall’esito incerto e di guadagnare alla corona l’ambito Principato di Taranto. L’affare fu concluso in tre giorni di trattative e al terzo giorno Ladislao potette finalmente ottenere Taranto, accolto dalla fidanzata – guerriera tutta splendente d’armi, la quale gli porse in un catino d’oro le chiavi della città bimare.
Lotta serrata per difendere il ruolo di Regina, dopo la morte del marito.
Il matrimonio fu celebrato dall’arcivescovo di Taranto nella cappella del castello il 23 aprile 1407. Un mese dopo, al termine della luna di miele, Maria partì per Napoli dove il re la raggiunse più tardi. Ma si vide assai presto che la nuova sposa non rappresentava per lui “che il coronamento felice di un piano di guerra”, il mezzo astuto per impadronirsi di un vasto e appetito territorio. Altre più giovani favorite, e prima fra tutte Maria Guindazzo, si disputavano già il talamo regale, quando l’impetuoso monarca non era impegnato sui campi di battaglia.
I tradimenti del coniuge però, non furono la sola fonte di amarezze. A corte ella doveva guardarsi dalla prepotente cognata Giovanna, la futura regina la quale, dopo la morte prematura di Ladislao avvenuta il 6 agosto 1414, le prese in ostaggio il secondogenito Gabriele. Ma, anche se a corte Maria “stava più a modo di prigioniera che di regina”, il suo orgoglio smisurato le permise di vivere all’altezza della propria fama, di concedere privilegi ai fidatissimi salentini del proprio staff e di emanare vari provvedimenti a beneficio dell’amata Terra d’Otranto.
Resa scaltra dai tempi e dalla conoscenza degli uomini, ancor prima di fare il gran salto matrimoniale, Maria si era adeguatamente tutelata da possibili colpi di mano ai danni suoi e del Principato di Taranto assumendo, con pubblico contratto, il condottiero Francesco Orsini e la sua compagnia di 330 lance e di 900 cavalli, per il semestre marzo – agosto 1407. Senonché, quattro giorni dopo, l’Orsini aveva stipulato patti analoghi con l’infedele re – marito. L’accorta donna, avuto sentore del doppio gioco, li aveva smascherati entrambi davanti al tribunale, esibendo le proprie scritture.
Lecce e il Salento entrano nella stagione del Rinascimento.
Nell’immaginario popolare Maria d’Enghien e la sua scelta di essere regina rimasero lungamente come metafore di grande sfortuna e infelicità. E il volgo, di fronte a casi di persone sfortunate, ricordava loro: Hai fatto il guadagno di Maria di Brenna. Ma Maria d’Enghien era tutt’altro che doma. Una serie di errori politici della cognata Giovanna, le permisero di rimpatriare nel 1415 in Terra d’Otranto. Dopo la sua proclamazione a regina nel 1419, rientrò in possesso del suo stato, parte del quale era stato usurpato. Ne fece riconoscere la legittimità nel 1420, previo versamento di 20.000 ducati.
Adoperò la forza contro baroni riottosi come Luigi San Severino, ma anche una saggia politica di concessioni. Maria d’Enghien ebbe di nuovo coscienza che “forza alcuna non valeva più a fermarla sul cammino della sua nuova ascesa”. Insieme al figlio Giovanni Antonio, destinato a ripetere le imprese del padre, impresse ai propri domini vivacità economica e territoriale, dinamismo cetuale, fervore di traffici, di cultura, di arte. Accentuò gradualmente l’autonomia del suo principato della corona, valorizzandone uomini e risorse e regolamentandolo con una saggia normativa locale (capitoli e statuti).
La piccola corte leccese di Madamma “con le sue esigenze di rappresentanza di cerimoniale e vita cortese”, introdusse Lecce e il Salento alla stagione rinascimentale. “Ne costituì per circa un quarantennio il volano per una crescita di qualità e quantità”. Anche il suo temperamento virile cominciò ad addolcirsi e con gli anni ella diventò pia e comprensiva. Intervenne spesso, e con discrezione, per bilanciare il carattere rude e irruento del primogenito Giovanni Antonio. Fu protagonista incontrastato delle vicende belliche e politiche del Mezzogiorno.
Ma fu pure madre giusta. Seppe assicurare agli altri figli una sistemazione principesca, degna delle stirpi di Brienne, dei d’Enghien e degli Orsini del Balzo. Maria d’Enghien morì a 79 anni il 9 maggio 1446. Ebbe sepoltura in un monumentale mausoleo che il principe Giovanni Antonio eresse nella prima chiesa di Santa Croce. Esso venne violato nel 1537 dalla soldataglia spagnola. Fu l’ultimo spregio alla grandezza di una donna, la quale aveva saputo elevarsi alla dignità di regina, e “superare nella realtà le fantastiche eroine dell’Ariosto e del Tasso”.
Fonte: “Le Salentine – Genio e condizione della Donna in Terra d’Otranto”